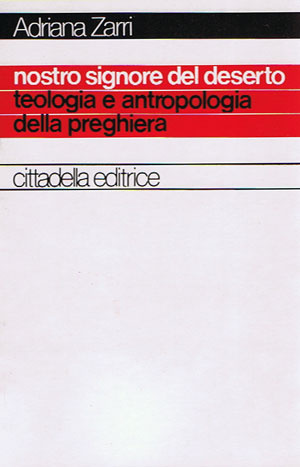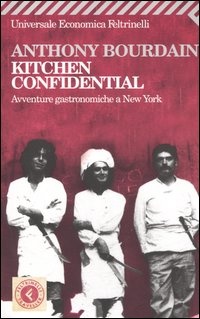I talenti della twitteratura – Ovvero: QUESTA INTRODUZIONE È SCRITTA IN FORMA BREVE PERCHÉ DEVE STARE IN 10.000 CARATTERI.
21 aprile 2010
qui di seguito l’introduzione alla sezione di micro-narrativa che ho curato per l’antologia di webletteratura appena pubblicata dall’editore Il Foglio.
***
Cosa hanno in comune i Fantaiku di Giulio Olleia, gli status facebook di Michelangelo Cianciosi, e le mie Storie da caffè, presenti in questa sezione? Oltre al fatto di essere pezzi di scrittura consegnati al web, intendo.
Beh, sono brevi – direte voi. Risposta esatta – rispondo io – ma incompleta: sono componimenti brevi, dotati di una precisa consapevolezza formale.
Andiamo con ordine. Si fa un gran parlare e scrivere della cosiddetta “twitteratura”.
Chi ne parla bene, dice che è un rinascimento letterario; in cui chiunque può scrivere qualunque cosa. Chi ne parla male, dice che è una barbarie letteraria; in cui chiunque può scrivere qualunque cosa.
In entrambi i casi, pare uno strumento potente consegnato nelle mani di individui che subito diventano soggetti scriventi. Non uso la parola “scrittori” deliberatamente, per restare criticamente neutrale tra le due parti. Preferisco indicare il loro punto di contatto, ossia l’osservazione che nella storia della cultura (nata, per inciso, con l’invenzione della scrittura) mai si era scritto così tanto.
Soggetti scriventi, dunque. Individuali o collettivi. Generanti un fiume in piena di narrazioni.
A questo punto, guardiamoci indietro, al secolo che ha coltivato più di ogni altro una passione smodata per le grandi narrazioni: l’ottocento. Un secolo totalmente invaghito del soggetto e della sua potenza. Pensate a Hegel e al suo storicismo dialettico. Ora associate al suo nome quello dell’idealismo filosofico e, subito dopo, quello del suo contraltare “sociale”, il marxismo. Poi allargate il campo al romanzo storico, e immaginate come colonna sonora di tutto questo le grandiose opere totali wagneriane. Nell’ottocento il Soggetto, individuale o collettivo, era maiuscolo: in grado di cambiare la Storia (maiuscola, pure); o, male che andasse, di raccontarla.
Una Storia di cui il Soggetto era in definitiva lo specchio, e viceversa.
Per raccontare – e raccontarsi – in tali e tante proporzioni, la struttura linguistica privilegiata era necessariamente il periodare ipotattico. Il pensiero umano si snocciola così, con concatenazioni lineari di causa ed effetto. E la sintassi ipotattica lineare ne è l’espressione linguistica fedele: una frase reggente, e di seguito frasi subordinate tra loro con tutti i legami di subordinazione previsti dalla sintassi stessa. In breve, costruzioni molto lunghe.
Con il novecento, qualcosa cambia. Le forme espressive iniziano a frammentarsi. Si cercano nuove configurazioni espressive per lasciar emergere idee nuove, e un nuovo modo di pensare. Ascoltiamo la musica di Anton Webern (chi non lo conosce googli, pls): nelle sue Sei Bagatelle per quartetto d’archi (1913) il suono vive soltanto nel proprio dialogo con le pause; e attraverso la tensione che ne scaturisce, la composizione musicale si apre alla paratassi.
Un po’ come nel montaggio filmico, la narrazione avviene nello spazio di confine tra una inquadratura e l’altra. Dalla giustapposizione, non dalla concatenazione. Il rapporto di causa ed effetto viene sospeso nella sua linearità logica e anche temporale. E allarga il suo campo semantico. Diventa una provocazione di senso, non dimostrazione.
La scrittura si costella così di frasi più brevi, coordinate tra loro; anziché subordinate. Mi spiego con un esempio, dall’espressionismo tedesco: la poesia di Trakl Im Winter (trad. it. di Vera degli Alberti e E. Innerkofler, D’inverno, in Le poesie, Garzanti, Milano, 1989): “Il campo risplende bianco e freddo / Il cielo è solitario e immenso / (…) Silenzio dimora in nere cime”. Ognuna di queste frasi è autonoma; il loro nesso, infatti, non discende da una logica di tipo sintattico, per cui il predicato di una frase regge il predicato delle altre. Al contrario, il nesso di queste frasi sta in quello che il predicato, di per sé, non vuole dire. Il campo risplende – il cielo è – silenzio dimora. Nella tensione di questi predicati si coglie il senso dell’intera poesia. Sono piani differenti, che non intendono collegarsi chiaramente, ma che si richiamano l’un l’altro attraverso l’utilizzo – coordinato, paratattico – di quei particolari predicati: il campo, attraverso il predicato risplende, si apre allo sguardo sulla luminosità del cielo, che quindi non ha bisogno di essere predicato come splendente, poiché ripeterebbe semplicemente il senso che già acquista dall’essere in tensione con la frase precedente: il cielo, di per sé, semplicemente è. A metà strada fra il campo ed il cielo – letterariamente e fisicamente – stanno le cime, in cui dimora, quindi, il plesso di predicati inerenti alle frasi precedenti (bianco e freddo – solitario e immenso), che Trakl attribuisce al soggetto logico, il silenzio. L’aggettivo nere, infatti, è attribuito alle cime, luogo in cui il silenzio semplicemente dimora: solo dalla tensione con un attributo che non gli è direttamente predicato, esso assume quell’attributo stesso quale indicazione del proprio senso.
Ho superato la metà del numero dei caratteri consentiti, per cui vado a chiudere.
Come avrete capito, se non vi siete già addormentati (internet può indurre un calo del tempo medio di attenzione a quello di uno snack – da cui l’espressione americana snack on media o media snacking – ma questa è un’altra storia…), la tesi che ho cercato velocemente di argomentare è che la twitteratura ha radici sia culturali sia formali più antiche e profonde di quanto si possa pensare.
Se non vi basta spingervi al primo novecento, cercate su wikipedia il poeta giapponese Basho: verso la fine del 1600 ha codificato la forma classica dell’haiku, una forma brevissima di scrittura poetica, una piccola cassa di risonanza della verità nascosta tra le pieghe dei suoi versi.
Ok – mi dirà qualcuno -, ma chi scrive su facebook / twitter / blog è in fondo un narcisista in cerca di facile popolarità. A questa diffusa obiezione lascio che sia il poeta Rilke a rispondere. Nel 1922, nei suoi Sonetti a Orfeo, scriveva: “Tutto ciò che incalza / sarà presto trascorso; / soltanto quel che indugia / è ciò che ci consacra. Parafrasato: la nostra parte più nobile, più sacra, è rivolta a creare qualcosa che abbia una durata, una persistenza, il che – nell’epoca dei social media – è decretato anche dal numero di likes che si riesce a raccogliere. 😉
Nostro Signore del deserto.
20 luglio 2009
Scoprii anni fa Adriana Zarri alla radio. Una voce sorridente. Intimamente femminile. Sottile ma decisa: lontana, ma ricca di tutto quello che ha incontrato lungo il percorso fino a qui. La stessa sensazione che ho ricevuto dalle sue pagine. Il conforto di un’intelligenza ispirata, che non parla mai per sé.
Kitchen confidential: cibo guasto per la mente.
17 luglio 2009
Una vecchia campagna pubblicitaria diceva “leggi un libro prima che hollywood lo rovini facendone un film”. Qui è il contrario: speriamo che hollywood ne faccia un film, sarà sicuramente migliore del libro.
La storia del cuoco bohemien genio (ma non troppo) e maledetto (ma forse solo pirla) salvato dall’immedesimazione con l’autorità dispotica da cui in adolescenza cercava di scappare è un po’ loffia, e mi fa pena che la sua fortuna sia costruita su chi, come lui, si lascia schiavizzare in nome del “sacro fuoco”. Se cucina come scrive, i suoi piatti saranno tutti rovinati a metà della cottura.
Quando uscirà il film lo andrò a vedere. Il libro finisce in seconda fila.
Romanzo crudo: J. G. Ballard, Millenium People
6 marzo 2009
Tutto inizia con una fine. La bomba di Heathrow non pone fine soltanto alla vita della ex-moglie di David Markham, psicologo londinese e voce narrante del romanzo. Soprattutto, ne uccide l’innocenza. Ballardianamente, una frattura nel mondo esterno rispecchia una frattura nel mondo interiore dei protagonisti. Che si agitano come piccole cavie in un esperimento condotto di capitolo in capitolo dall’autore per dimostrarci che “la middle-class è il nuovo proletariato”. Una tesi contraddittoria; a misura del fatto che ai protagonisti non restano in fondo che le loro stesse contraddizioni. E l’inquietudine che ci attraversa mentre leggiamo è quella di scoprire che quelle contraddizioni sono già le nostre.
Con Millenium People, J. G. Ballard chiude la trilogia (dopo Cocaine Nights e Super Cannes) di detective-thrillers sui falsi miti del consumismo. Con un’eco di Fight Club, certo, ma con in più una lucidissima analisi delle contraddizioni del benessere che a rifletterci un attimo dovrebbe togliere il fiato. Buona apnea.